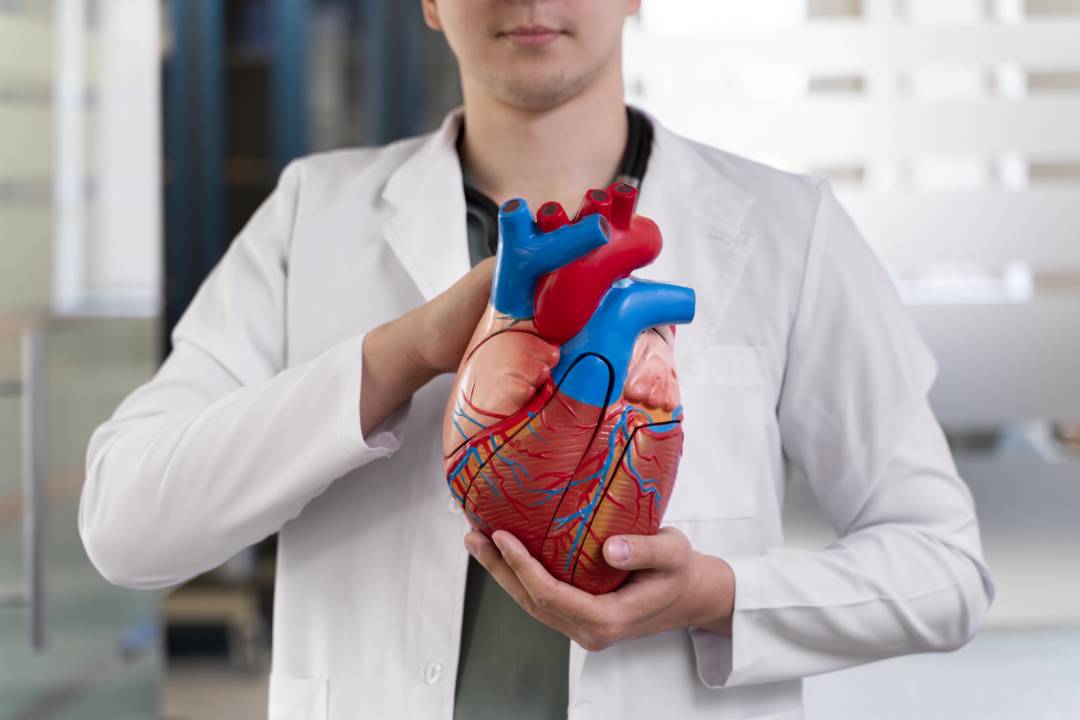Che cos’è la fibrillazione atriale?
La fibrillazione atriale è un’aritmia cardiaca caratterizzata da un’attività elettrica rapida e irregolare degli atri, che causa la perdita della loro contrazione efficace. Questa condizione può portare alla formazione di coaguli di sangue all’interno delle camere cardiache, aumentando il rischio di eventi tromboembolici, come l’ictus. Per questo motivo, spesso si rende necessaria una terapia anticoagulante cronica.
Oltre ai rischi legati ai coaguli, la perdita della contrazione atriale riduce l’efficienza del cuore come pompa, causando sintomi quali affaticamento, dispnea (difficoltà a respirare) e debolezza. Sebbene questa aritmia sia compatibile con la vita, può influire negativamente sulla qualità di vita del paziente.
Quali sono le cause della fibrillazione atriale?
Tra le cause principali si possono includere:
- Patologie cardiache strutturali, come difetti delle valvole o cardiopatie congenite.
- Fattori esterni, tra cui l’assunzione di farmaci, abuso di alcol, caffeina o tabacco.
- Disturbi metabolici o sistemici, come ipertiroidismo o apnea notturna.
In alcuni casi (30%), la fibrillazione atriale si manifesta in soggetti senza altre patologie cardiache, configurandosi come fibrillazione atriale isolata. Quando è associata a difetti strutturali, viene definita fibrillazione atriale concomitante.
Come viene diagnosticata la fibrillazione atriale?
La diagnosi si basa su un esame obiettivo, un elettrocardiogramma (ECG) o il monitoraggio continuo con ECG Holter. La fibrillazione atriale può essere classificata in:
- Parossistica: episodi che si risolvono spontaneamente in meno di una settimana.
- Persistente: episodi che richiedono interventi terapeutici per terminare.
- Permanente: episodi che non rispondono a trattamenti disponibili.
Che cos’è l’ablazione chirurgica della fibrillazione atriale?
L’ablazione chirurgica è un trattamento riservato ai casi in cui la terapia farmacologica e la cardioversione elettrica non hanno successo nel controllo del ritmo o della frequenza cardiaca, e i sintomi sono invalidanti. La procedura consiste nel creare lesioni controllate nel tessuto atriale per isolare elettricamente le aree che originano l’aritmia. Questo permette di interrompere i circuiti elettrici anomali responsabili della fibrillazione atriale.
Come si esegue l’intervento?
- Ablazione transcatetere: meno invasiva, indicata per fibrillazione atriale isolata.
- Ablazione chirurgica: spesso associata alla chiusura dell’auricola sinistra, una struttura in cui si formano frequentemente coaguli.
Le tecniche chirurgiche variano in base al tipo di fibrillazione e alla presenza di patologie concomitanti:
- Toracoscopia bilaterale: utilizzata per casi parossistici, con minima invasività.
- Minitoracotomia con circolazione extracorporea: usata per fibrillazione persistente o cronica.
- Sternotomia o intervento combinato: indicato in presenza di patologie cardiache strutturali.
Il successo dell’intervento varia tra il 70% e il 90%, in base alla durata e al tipo di fibrillazione atriale.
Quali sono i rischi dell’intervento?
Essendo un intervento chirurgico, comporta rischi come:
- Sanguinamento.
- Infezioni.
- Danno neurologico.
- Possibile necessità di impianto di un pacemaker.
Cosa succede dopo l’intervento?
Dopo l’ablazione, il paziente trascorre 12-24 ore in terapia intensiva prima di essere trasferito in reparto. La degenza ospedaliera dura circa 4-5 giorni, seguita da un periodo di riabilitazione cardiologica di circa 15 giorni o da un recupero domiciliare, a seconda dei casi.
Conclusioni
L’ablazione chirurgica della fibrillazione atriale rappresenta un’opzione terapeutica efficace per migliorare il ritmo cardiaco, ridurre i rischi di complicanze e migliorare la qualità della vita dei pazienti. Ogni trattamento deve essere personalizzato in base alle condizioni cliniche e alle caratteristiche del paziente.